Le origini del cognome Sernicola
(e dei cognomi Sernicoli, Sarnicola, Sornicola, Fernicola)
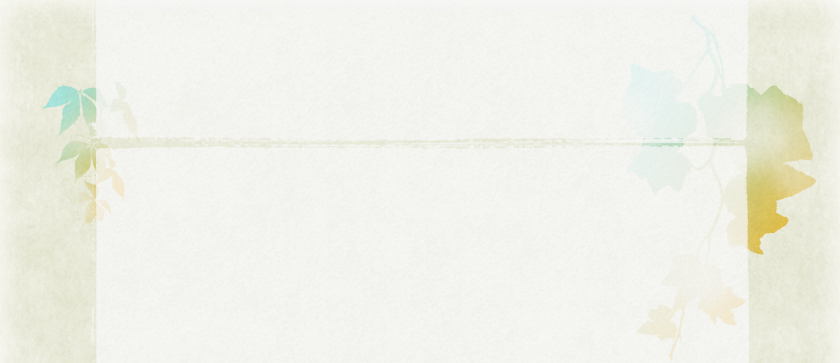
Le origini del cognome Sernicola
(e dei cognomi Sernicoli, Sarnicola, Sornicola, Fernicola)
Come nasce il cognome Sernicola?
Quasi tutti i cognomi italiani derivano da sostantivi o aggettivi e hanno tre tipi di formazione:
a) patronimica, quando contengono un riferimento al nome (proprio) di un genitore, che talvolta poteva anche essere accompagnato da una nome (comune) indicante una attività (De Luca, Zorzi, Notarbartolo, Mastroianni);
b) toponimica, quando il riferimento è di tipo geografico, quindi se è in qualche modo indicata - con un nome comune o proprio o anche con un aggettivo - la provenienza da una contrada, una città, una regione o una nazione (Collina, Lucchese, Lombardo, Alemanno);
c) attributiva, e in questo caso il riferimento è a caratteristiche reali o di fantasia, che si riferiscono all’aspetto fisico, all’attività lavorativa, alle qualità morali, e possiamo trovare nomi comuni e soprattutto aggettivi (Russo, Altobelli, Scarparo, Zavattaro, Carissimo).
Il cognome Sernicola contiene un nome proprio (Nicola) e questo ci consente subito di collocarlo nella prima delle tre tipologie sopra accennate.
Il De Felice avvicina il cognome Sernicola ad altri simili (Serandrei, Serangeli e Seragnoli, Serantoni, Serazzi, Serguidi, Serianni, Sermarini, Sermasi, Sermenghi, Serpieri, Serristori e Serughi) quali cognomi composti dalla forma base ‘Seri’ (cognome “rarissimo e sporadico”) che deriva dal “titolo d’onore sère (dal latino senior = ‘anziano’) comune dal Medioevo al Rinascimento soprattutto nella forma atona ridotta ser preposta al nome di sacerdoti, notari, alti funzionari e persone di riguardo”. Il De Felice poi non trascura di segnalare molto opportunamente per la forma Sernicola una origine meridionale. Inoltre aggiunge un rimando ai cognomi analoghi Sire, Sirangelo, Sirgiovanni, Sirleo, Sirimarco, Sirrao (che sono più comuni in Calabria) e ai cognomi Messeri, Messere (Toscana) e Missier (Veneto) (Emidio De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, Milano 1978).
Ma già Gennaro Grande nel Settecento, che conosceva questo cognome diffuso nel Regno di Napoli, lo indicò come esempio, insieme ad altri, di derivazione dalla forma sere (ser) accompagnata da nome proprio (Gennaro Grande, Origine de' cognomi gentilizj nel Regno di Napoli, Napoli 1756, p. 219). La testimonianza del Grande ci conforta sul fatto che cognomi che derivano dalla forma ‘ser’ erano diffusi anche nel Meridione d’Italia.
Per comprendere il processo di formazione del cognome, aggiungiamo che è vero, come dice il De Felice, che dal lat. senior deriva ser, ma probabilmente l’uso nell’Italia medievale del titolo ‘ser’ deve essere stato mutuato dalla Francia dove il senior/ser era già diventato ‘mon sieur’ ed è quindi arrivato in realtà nelle forme 'missor', 'misser' e ‘messer’ poi ridottesi nuovamente a “ser”. Possiamo inoltre aggiungere che “messere” è appellativo usato in larga misura nell’Italia centrale già dal Duecento e per diversi secoli, mentre nell’Italia meridionale (dove è ben vero che già dal tempo dei normanni e degli svevi si usava la forma 'sire') sembra limitato ad un arco temporale più ristretto: nel periodo tardo-angioino (fine Trecento) e in quello aragonese (Quattrocento) e in conseguenza delle influenze culturali e commerciali provenienti contemporaneamente dalla Toscana e dalla Francia.
Quindi, possiamo immaginare che, forse nel corso del Quattrocento, il nostro antenato, che di nome faceva Nicola (Nicolaus, Nicolas, ecc.) e che per qualche motivo non aveva uno specifico cognome familiare, per distinguersi da altri Nicola, era conosciuto dalla comunità nella quale viveva come ‘messer Nicola’ (o, più semplicemente, ‘ser Nicola’) forse perché era un notaio o un signorotto o magari, come ricorda il De Felice, un prelato (?). I suoi figli vennero quindi identificati come ‘Tizio’ e ‘Caio’ di Ser Nicola e poi di Sernicola, dando origine al cognome di famiglia.
Dove nasce il cognome Sernicola?
Se consultiamo gli attuali elenchi degli abbonati al telefono in Italia, possiamo constatare che il cognome Sernicola ricorre poco meno di un centinaio di volte, facendone quindi un cognome poco diffuso: si può ipotizzare che gli italiani che portano oggi il cognome Sernicola siano in totale non più di tre-quattrocento. La diffusione geografica di questi cognomi, poi, così come risulta dalle statistiche che si possono evincere dalle stesse Pagine Bianche, è assolutamente individuabile in Campania, nella provincia di Salerno, nel Cilento in particolare (50%): in questa area c’è anche una rilevante presenza di Sarnicola (58), di Sornicola (8) e soprattutto di Fernicola (143), tutte forme che derivano in maniera evidente dalla primitiva Sernicola.
Un’altra cospicua presenza di Sernicola (il restante 50%) si riscontra in un'area geografica che ha come epicentro il comune di Calvi dell’Umbria (TR) e il confinante comune di Magliano Sabina (RI): in questa area non si riscontrato varianti fonetiche, ma l'interessante compresenza del cognome Sernicoli, oggi tuttavia meno diffuso che in passato.
Le nostre prime indagini storiche indirizzate nel Salernitano ci hanno consentito presto di scoprire che documenti notarili molto antichi (sec. XVI-XVIII) conservati presso l’Archivio di Stato di Salerno attestano la massiccia presenza di Sernicola nella città di Pollica e nel casale di Capograssi (oggi frazione del comune di Serramezzana, provincia di Salerno). Inoltre nel censimento della popolazione del Cilento del 1489, risultano in tutta la regione solo tre gruppi familiari Sernicola (ma, ad una attenta analisi, sarebbe più preciso dire due) e limitatamente al casale di Capograssi. Queste prime risultanze delle indagini ci possono fare affermare che il cognome Sernicola (almeno in questo stipite) ha avuto origine nel casale di Capograssi, che si è poi spostato nella limitrofa località di Pollica (uno dei maggiori centri del Cilento nei secoli XVI-XVII), per andare infine a interessare le grandi città di Salerno e Napoli in momenti diversi tra Sei, Sette e Ottocento. Altri rami della famiglia nel frattempo si trasferivano nelle località di Agropoli, Capaccio, Battipaglia, Laurino portando le varianti fonetiche che abbiamo sopra ricordato (soprattutto Sarnicola e Fernicola).
Inoltre sappiamo che un messer Nicola aveva legato il suo nome ad un toponimo (anzi un micro-toponimo, oggi probabilmente scomparso) proprio nella zona del Cilento: in un passaggio degli Statuti di Novi Velia, che risalgono alla metà del XV secolo, viene citato un "ponte di Messer Nicola" nei pressi di Ceraso, non distante da un "bosco di Messer Roberto" (Statuti di Novi. Cap. I Demanio; v. Pietro Ebner, La Baronia di Novi. Storia di un feudo del Mezzogiorno, Roma 1973, pp. 150-151). Questo messer Nicola e questo messer Roberto potrebbero essere i fratelli Roberto e Nicola Sanseverino, signori di quei luoghi? ma messer Nicola Sanseverino potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con l’origine del cognome Sernicola?
Sernicola sono attestati anche nella regione sabina (a Calvi dell'Umbria) già dai primissimi anni del Cinquecento. Da questo ceppo si differenzia un ramo che comincia a usare la forma Sernicoli in un periodo imprecisato (nel XVII secolo ?) e comunque mai in maniera univoca, almeno a giudicare dai libri dei battesimi delle parrocchie di Calvi e persino dai catasti, dove le stesse persone sono talvolta registrate (addirittura nella stessa pagina!) sia nella forma Sernicola sia in quella Sernicoli.
Sono attestati nella regione una grandissima quantità di cognomi similari (Serpieri, Servaleri, Sercesari, Sersantis, ecc.) tutti derivanti dalla formazione classica “figlio di <mes>ser … ”: nell’Italia centrale infatti è avvenuto il più ampio e diffuso fenomeno della formazione di questi cognomi contenenti la forma ‘ser’, come afferma il De Felice. Ma è doveroso aggiungere tuttavia che nel territorio di Calvi dell'Umbria il cognome Sernicola/Sernicoli è l'unico della tipologia Ser-(patronimico). La forma del cognome nasce con i figli e i nipoti di un ser Nicola di Lorenzo, il cui omonimo nipote era notaio a Calvi nella seconda metà del XV secolo noto come Nicola di Antonio di ser Nicola.
E poi va ricordato che una famiglia Sernicoli è documentata a Matelica dal XV secolo fino alla sua presunta estinzione a metà Seicento. Anche per questo ramo è stato individuato il capostipite che dai documenti risulta essere il notaio ser Nicola figlio di ser Giovanni di ser Marco attivo a Matelica nella seconda metà del Quattrocento. Il padre Giovanni, anche egli notaio, rogava a Matelica ma era originario di Gualdo Tadino (ser Johannes ser Marci de Gualdo nucerine diocesis).
Quando nasce il cognome Sernicola?
Possiamo dire, in maniera molto generica e con le dovute eccezioni, che i primi cognomi nascono in Italia tra XI e XII secolo, ma si diffondono in maniera capillare tra il XIII-XIV secolo (Italia centrale e settentrionale) e il XIV-XV secolo (Italia meridionale).
Prima di allora, per tutto l'alto Medioevo (secc. V-XI), cioè il periodo successivo alla caduta dell’Impero Romano e alla perdita delle consuetudini che esso aveva diffuso in tutta l’Europa, ciascun individuo veniva identificato con il solo nome di battesimo e, quando era necessario distinguersi da un omonimo, al nome proprio si aggiungeva - in una maniera che oggi definiremmo informale o occasionale cioè non codificata - un attributo, oppure il nome del padre o della località di provenienza: e proprio queste “aggiunte” determineranno la nascita dei cognomi. Inizialmente però questo termine che accompagnava il nome (cum nomine = cognome) il più delle volte serviva a connotare soltanto un individuo e non la sua discendenza. Solo dopo – appunto – diventano dei cognomi che servono a individuare una famiglia, cioè il cognome comincia a trasmettersi di padre in figlio (e rarissimamente da madre in figlio).
Le risultanze delle ricerche effettuate finora ci dicono che il cognome Sernicola non sembra attestato in alcun luogo d’Italia prima della metà del XV secolo (il primo documento che conosciamo in cui la forma Ser-Nicola è usata come cognome è del 1459).

Il signum del notaio di Matelica
ser Nicolaus ser Johannis ser Marci (seconda metà del XV sec.)
Archivio di Stato di Camerino